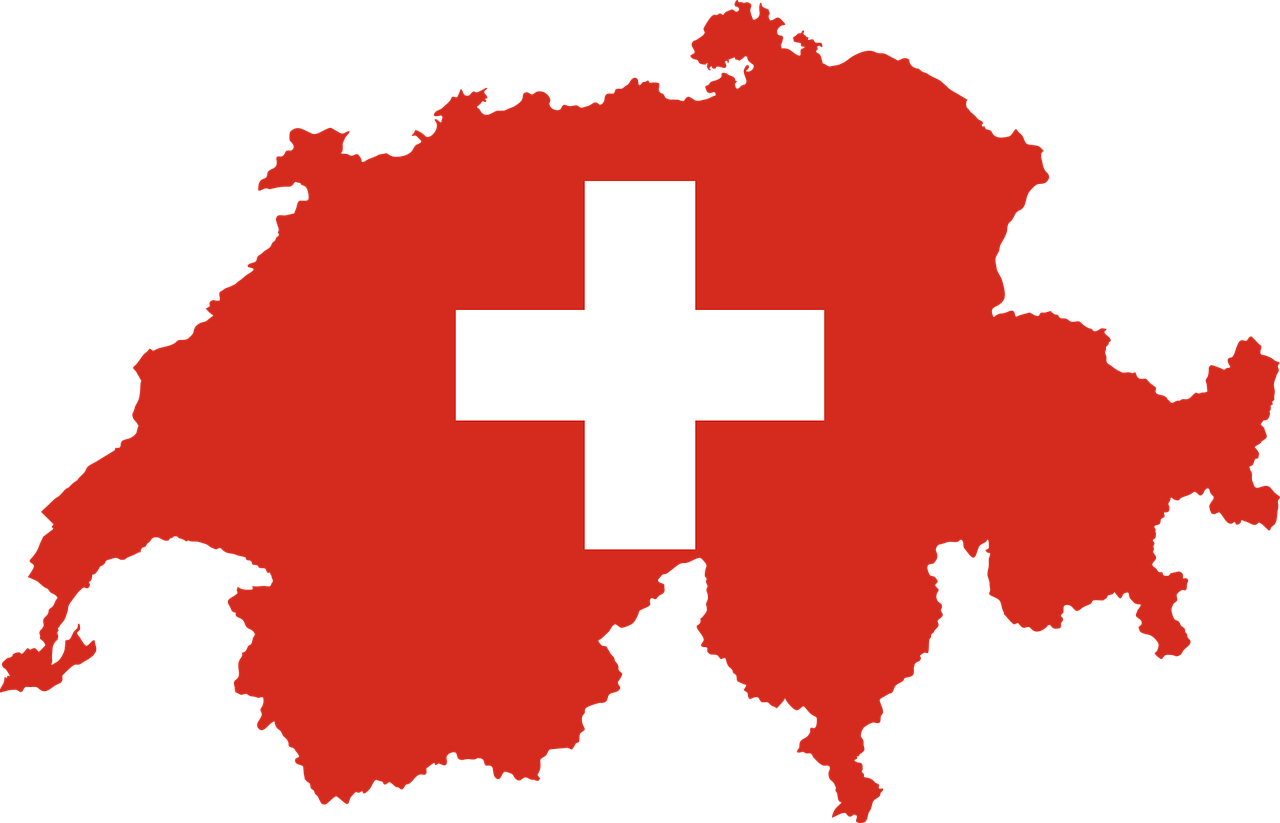di Roberto Marraccini
Perché il 9 maggio è la Festa dell’Europa
Oggi l’Europa, almeno come idea primigenia di costruzione di una unità di intenti tra Stati e popoli diversi, compie 74 anni. La data di riferimento di questo anniversario è da ritrovare – andando a ritroso nel passato – il 9 maggio del 1950. La data celebrativa, “Giorno dell’Europa” o “Festa dell’Europa”, venne decisa nel corso del vertice europeo di Milano (nel 1985). Essa coincide con l’anniversario della famosa e diventata storica, Dichiarazione Schuman, dal nome del Ministro degli Esteri francese, Robert Schuman, che la espose il 9 maggio del 1950, a Parigi.
L’idea di Unità dell’Europa
La Dichiarazione Schuman è ritenuta il vero e proprio documento fondatore del processo di unificazione europea. In quella dichiarazione, Schuman presentò quelle che erano le sue idee circa una nuova forma di cooperazione politica per il futuro dell’Europa. Obiettivo non nascosto e apertamente dichiarato, tra l’altro molto ambizioso visto il periodo temporale appena successivo al secondo conflitto mondiale, era di procedere alla realizzazione di una istituzione europea che potesse mettere – in comune – la gestione e produzione del carbone e dell’acciaio. Quello fu il primo embrione di quella che divenne poi, successivamente, la Comunità Europea.
L’idea di unità dell’Europa, affascinante e che nella storia ha svariati interpreti, pur essendo presente come idea/teoria fin dal Medioevo, diviene – concretamente – un obiettivo politico comune, solo dopo la fine del secondo conflitto mondiale. Viene ritenuta, in quel momento, una idea da concretizzare istituzionalmente e poi legislativamente.
Alla fine di quel conflitto bellico, l’Europa si trovava in una situazione drammatica. Era completamente martoriata dalle distruzioni materiali e psicologiche derivanti dal conflitto e necessitava di risollevarsi.
In quello scenario, l’ordine mondiale venne spartito in due aree di influenza geo-politica: da una parte gli Stati Uniti e dall’altra l’Unione Sovietica con l’ideologia comunista che portava con sé. Gli stati europei, quindi, perdendo la loro posizione dominante regredirono al rango di satelliti delle due superpotenze, ed inseriti all’interno del complesso meccanismo della Guerra Fredda.
Fino dunque al secondo conflitto mondiale, non si era mai parlato e discusso con una convinzione non semplicemente utopistica – tranne rare eccezioni – di costruire una Europa unita ed integrata.
Con la fine delle ostilità, si cercò di portare pace e sicurezza in Europa, e questo era possibile con una collaborazione sul terreno militare tra gli Stati dell’Europa occidentale. Da ciò nasce poi la condizione politica della collaborazione sul piano economico.
I pionieri dell’Europa e l’idea federale
L’ideatore del progetto di unificazione europea – oltre ad alcuni esponenti del Risorgimento italiano come Carlo Cattaneo che invocava gli Stati Uniti d’Europa – fu Altiero Spinelli, che puntò decisamente sul ruolo costituente del Parlamento europeo. Nel suo famoso Manifesto di Ventotene (scritto tra il 1943 e il 1945 nel suo esilio durante il regime fascista) lascia intravedere la possibilità della nascita di un’Europa integrata che, nella sua visione strategica, avrebbe dovuto essere costruita su un’architettura federale. Nasce l’idea del federalismo europeo, del federalismo sovranazionale.
Comunque, la prima pietra per la costruzione di un embrione di Comunità europea fu posta proprio con la Dichiarazione Schuman. Partendo, come detto, dal mettere in comune la produzione e gestione del carbone e dell’acciaio si voleva giungere – con il tempo – alla formazione di un’unione economica tra gli Stati europei.
Successivamente, a seguito della Dichiarazione Schuman, venne firmato a Parigi, il 18 aprile del 1951, il primo dei Trattati comunitari, per l’istituzione della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA). I paesi aderenti erano: Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo ed Italia.
Il futuro dell’unità europea
Settantaquattro anni dopo l’Europa celebra questo anniversario minacciata da un pericolo diverso, ma la cui drammaticità non mette meno a rischio la sua coesione e il suo futuro. Oggi, occorre interrogarci ed in profondità sul percorso compiuto dall’integrazione europea e dall’unità dell’Europa, partendo proprio dalle basi ideali poste in quel documento. Divisioni, nazionalismi che risorgono, minacce di barriere da elevare che vengono paventate, stanno – purtroppo – minacciando di far tornare indietro la storia dell’integrazione comunitaria. Le emergenze in atto (es. guerra in Ucraina, il ritorno del conflitto in Medio Oriente tra Israele e Hamas ecc.) stanno ancora di più rafforzando e facendo emergere quelle divisioni che vorrebbero interrompere il percorso voluto, sognato e per cui hanno lottato i Padri Fondatori dell’Europa.
Ma interrogandoci capiremo, anche, che la strada percorsa fino ad oggi è quella giusta, pur essendo ancora lunga. Il traguardo finale è, forse, un sogno; ma è con i sogni che si costruisce, ogni giorno, la concretezza della vita. L’Europa deve ripartire, anche nel suo progetto istituzionale; come ci aveva indicato Schuman, verso una vera Unità tra i popoli d’Europa. Verso gli Stati Uniti d’Europa.